
Dove siamo
Libreria Antiquaria Dentis
Via San Tommaso 5
10122 Torino TO
Orari di apertura
Martedì a Sabato: 11:00 - 19:00
Domenica e Lunedì: chiuso
Contatti
Tel: +39 011.544.887
Mobile/WhatsApp: +39 349 7536.827
Emai: dentisrarebooks@hotmail.it
#dentisrarebooks
LIBRERIA ANTIQUARIA DENTIS di Dario Paolo Dentis © Copyright 2025 - All rights reserved - P.IVA 09146510012
Giovanni, Vialardi. Cucina borghese, semplice ed economica […] Edizione adorna di molte incisioni in legno con copioso Indice generale. Servizio alla Borghese, Francese e Russa-800 ricette di cucina-350 di dolci. Torino, G. Favalle Editori, 1863.
gastronomia, cucina, pasticceria, prima edizione, vino, ricette
€450.00 (In Stock)
Torino, G. Favalle Editori, 1863. In-8° (17,8 cm x 11,4 cm). Pp. 470. legatura coeva mezza pelle blu, autore e titolo dorati sul dorso. Frontespizio entro bella bordura figurata in xilografia formata da vignette raffiguranti cornucopie, vivande sopraffine e utensili da cucina. Con diverse illustrazioni xilografiche n.t. Qualche fioritura al margine inferiore di alcune pp. e modesti segni del tempo, peraltro esemplare in stato di conservazione molto buono, inconsueto nei libri cucina.
Prima edizione di questa celebre opera di gastronomia in cui si ritrovano enunciati i principi di una cucina borghese diretta principalmente ai maestri di casa ed alle donne casalinghe, dall' introduzione: “ricercasi oggidì una cucina sana, semplice, economica e borghese, cioè adatta a ogni ceto; per cui credetti bene d’attenermi alla medesima e darne un trattatello”. Il biellese Vialardi fu il primo ad introdurre le quantità esatte degli ingredienti nelle ricette descritte nei suoi lavori. L' opera comprende 800 ricette di cucina varia e 350 di dolci, concerne: le zuppe, le salse, le guarnizioni, le fritture, la carne, il pesce, la selvaggina, la volaglia, la verdura, le composte, i gelati e i sorbetti, le creme, le gelatine, la pasticceria, le confetture, gli sciroppi, il miele, i confetti, le bevande analcoliche, il ratafià, i liquori, ecc. Oltre queste ricette, definite “alla casalinga”, “per le famiglie”, “alla cittadina” o “alla borghese” è anche presente una scelta di piatti adatti per la cura omeopatica e pei giorni di digiuno, anche un' ampia disamina su come organizzare il “servizio alla borghese, francese e russa” e uno spazio dedicato alla “conservazione delle sostanze alimentari”. Le ricette si fanno più semplici, più attente alla spesa: lo spreco è messo al bando e fanno la loro comparsa testi monografici sul recupero degli avanzi. I prodotti locali e facilmente reperibili sono preferiti a quelli esotici e costosi, un tempo status symbol della nobiltà. Vengono inventati piatti con i nuovi cibi giunti dalle Americhe – patata, pomodoro, melanzana, mais – che soprattutto le ragioni della fame hanno contribuito a diffondere, nonostante le iniziali diffidenze. Per venire incontro alle esigenze della classe borghese, vengono messe a punto tecniche di conservazione dei cibi che snelliscono le preparazioni quotidiane: dal brodo in tavoletta alle conserve vegetali di Nicolas Appert, del cui metodo di conservazione dei prodotti alimentari lo stesso Vialardi parla nel suo trattato, intuendone la modernità. La semplicità dei cibi non è soltanto veicolo di risparmio e di benessere, ma anche di igiene e salute. La "Cucina Borghese" è molto interessante proprio perché nasce nel momento in cui la classe borghese cresce e desidera affermarsi e, contrariamente alla nobiltà, mira a mangiare bene, spendendo poco. Proprio per rispondere al bisogno di qualità e parsimonia, Vialardi recupera le ricette più intriganti, economiche e facili da realizzare della cucina di corte (come le Patate fritte ritenute adatte ai bambini), per riproporle in un ricettario in cui emerge, per la prima volta, l’ importanza del ruolo della donna di casa, che sovrintende alle attività della cucina, spesso senza cucinare di persona perché dispone di personale di servizio.
Il Vialardi, ben noto nell'ambito della gastronomia ottocentesca, fu aiutante cuoco e pasticciere di Carlo Alberto e poi di Vittorio Emanuele II. Nel 1824, appena ventenne, fu ammesso, quale aiutante di cucina della Real Casa, al servizio di Carlo Alberto con uno stipendio annuo di 960 lire. Nel 1845 diventò aiutante capo e nel ’48 giunge a essere capo cuoco e pasticciere, carica che mantenne fino all' andata in pensione nel 1853., coadiuvato nel lavoro da oltre un centinaio di persone. Di lui è particolarmente apprezzata l' arte nelle scenografiche costruzioni in "pastillage" (pastigliaggio), utilizzate per adornare le tavole reali.
Bibliografia: B.I.N.G., 2035; Paleari-Henssler, I, p. 754.
.png)
.png)
.png)
.png)


.png)

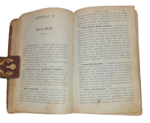

.png)
.png)



.png)

In Stock





In Stock
.png)
.png)
.png)


.png)
.png)


.png)



In Stock


.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock


.png)




.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)



In Stock


.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock


.png)
.png)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock







.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


.png)


In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock
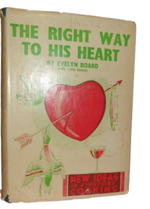
.png)

.png)
.png)
.png)
In Stock







.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock






.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock





In Stock





In Stock





In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)






In Stock








.png)
.png)
In Stock
.png)
.png)
.png)

.png)


In Stock

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


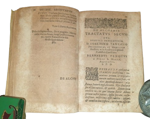
.png)


.png)
.png)



.png)

In Stock





In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


.png)
In Stock





In Stock





In Stock





In Stock







In Stock





In Stock
.png)
.png)
.png)
In Stock





In Stock
.png)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock





In Stock










.png)
.png)
.png)
In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)



In Stock





In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock

.png)







.png)
.png)


.png)
In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


.png)



.png)
.png)



In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


In Stock


.png)

.png)
In Stock

.png)

.png)
.png)
.png)
.png)

In Stock

.png)
.png)

.png)
.png)
In Stock

.png)





.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock






In Stock





In Stock





In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock





In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock





In Stock







.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)



In Stock

.png)
.png)
.png)
In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock



In Stock





In Stock

.png)
.png)
.png)

.png)



.png)
.png)



.png)


















In Stock






In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock





In Stock









In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock





In Stock






In Stock





In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock



In Stock





In Stock





In Stock


In Stock





















In Stock

.png)
.png)
.png)




.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock

.png)
.png)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

.png)


.png)
In Stock






.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock





In Stock





In Stock


















In Stock


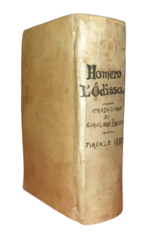






.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock














In Stock





In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock





In Stock


.png)


In Stock

In Stock
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
In Stock





.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock





In Stock




In Stock


.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

In Stock



.png)














In Stock





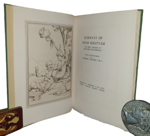










In Stock







In Stock





In Stock





In Stock





.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock























In Stock

.png)

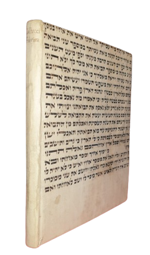





.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock








In Stock

In Stock





In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock





In Stock




In Stock








.png)
.png)
.png)
In Stock



.png)


.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock





In Stock

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


.png)



.png)




.png)




In Stock





.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock





In Stock



In Stock








.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock





In Stock




In Stock








.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock


.png)

In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock
.png)

.png)
.png)
.png)

.png)
In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock


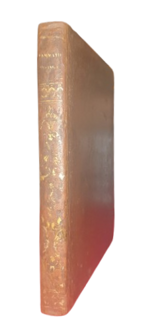



.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock





In Stock




.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


.png)



.png)
.png)
Out Of Stock





.png)
.png)
In Stock












In Stock








.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock





In Stock





In Stock




In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)






.png)



.png)
.png)



.png)

In Stock
.png)

.png)
In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


.png)
.png)

.png)
.png)
.png)



.png)
.png)

In Stock











In Stock







.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock





In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock
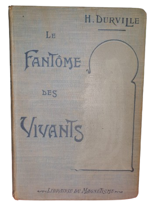




.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock





In Stock







.png)
In Stock
.png)


.png)

.png)
.png)
.png)
.png)



.png)
.png)
.png)
In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)


.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock






.png)
In Stock
.png)
.png)
.png)


.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)






In Stock



















In Stock








.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock









In Stock

.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock


.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock





In Stock







.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

In Stock




In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock







In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
.png)
.png)
In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)





.png)


.png)



.png)
In Stock



.png)
.png)
.png)









In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock
.png)
.png)
.png)

.png)
In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


.png)
.png)

In Stock
.png)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock






.png)
.png)
In Stock





In Stock





In Stock












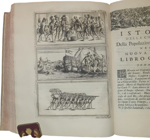
In Stock






.png)
In Stock




In Stock





In Stock
















.png)

















.png)
.png)









In Stock





In Stock
.png)
.png)

.png)
.png)
In Stock







In Stock

.png)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock
.png)








.png)
.png)





.png)
.png)

In Stock
.png)
.png)
.png)

.png)
In Stock













In Stock







In Stock
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock











.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
In Stock





















.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)



.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)










.png)
.png)
.png)
.png)
.png)








.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)














.png)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)





.png)
.png)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


.png)










.png)
.png)
.png)
.png)





.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)













.png)
.png)
.png)
.png)
.png)










.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)





.png)
.png)
.png)
.png)
.png)












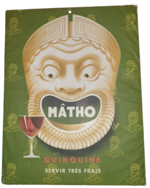



.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


























































.png)
.png)
.png)
.png)
.png)